ultimo capitolo di "La bandiera dell'anticristo"
LUCE NELLE TENEBRE
Il cristiano non pensa. Se pensa non sarebbe più cristiano. Perché
comprenderebbe la spaventosa assurdità dei dogmi che la sua fede
gl’impone e le miserabili contraddizioni fra le quali lo costringe a
dibattersi.
Prendiamo, ad esempio, l’eucaristia. Essa non è, come comunemente si crede, un semplice simbolo. A tale riguardo la chiesa
non transige ed il Concilio di Trento lancia la scomunica maggiore
contro colui che oserà negare «che il corpo, il sangue, l’anima e
l’esistenza divina, in una parola Cristo tutto intero, non siano in
realtà entro l’ostia ed il calice». (Canone I).
Ed aggiunge al
canone VIII: «Se qualcuno dice che Gesù, nell’eucaristia, non è mangiato
che spiritualmente, e non sacramentalmente e realmente, colui sia
anatemizzato».
Il comunicando mangia dunque effettivamente l’uomo-dio come nel banchetto totemico il selvaggio australiano mangia l’animale che considera sacro. Ed entrambi fanno
finire nel loro stomaco la divinità che amano, rispettano, adorano,
venerano.
Lo stomaco digerisce i cibi. Quindi digerisce anche
l’ostia miracolosamente trasformatasi in tutta la carne e in tutto il
sangue di Cristo. E, dopo la digestione, una parte del corpo di Gesù
diventa nostro sangue; un’altra parte passa nell’intestino; da dove poi
segue la sorte d’ogni cibo da noi mangiato e digerito e perciò è anche
la sorte dell’ostia della quale, dopo la consacrazione, non resta che
l’apparenza, mentr’essa, in realtà, si è mutata nel corpo e nel sangue
del Nazzareno (Concilio di Trento, Canone II).
Cristo, se esistesse
veramente e fosse dio, dovrebbe sbattere all’inferno coloro che,
esaltandolo ed adorandolo, lo riducono materia cambronniana e lo
relegano nel tempio del pozzo nero.
Tempo fa nel parlamento della
repubblica (del S. Cuore) italiana il molto onorevole democristiano
Monterisi ha tuonato contro l’anarchico Donato Giordano, custode del
cimitero di Canosa, accusandolo di avere bruciato il cadavere di un noto
fascista.
L’imputato è stato assolto in istruttoria, per non avere
commesso il fatto, da magistrati che non erano certo ben disposti verso
lui per le idee che professa.
Quindi ciò dimostra che il troppo
onorevole baciapile Monterisi ha calunniato un innocente. Ma se anche il
fatto fosse risultato vero, il meno indicato a scandalizzarsene sarebbe
stato proprio uno di quei zelanti sostenitori della chiesa cattolica la
quale di vivi e di morti ne ha bruciati a bizzeffe.
Per i vivi
hanno pensato gl’inquisitori. La sola Inquisizione di Spagna, iniziatasi
nel 1209, dette 429.067 vittime secondo i dati cattolici (Bandiera
Catholica, giornale clericale spagnolo, 29 luglio 1883). Aggiungiamo a
queste tutte le altre vittime arse vive dall’Inquisizione negli altri
paesi e otterremo la cifra di milioni di assassinati.
Nemmeno il
pentimento valeva a salvare gli eretici. Con una mirabile applicazione
dei principi cristiani di amore, carità e perdono delle offese, i preti
non risparmiavano coloro stessi che facevano ammenda dei presunti falli.
Un editto del 1535 di Maria d’Ungheria stabiliva che «in caso di
pentimento gli uomini siano uccisi con la clava, le donne sepolte vive.
Se non vi è pentimento gli uomini e le donne siano bruciati vivi».
La Cecilia nella sua «Storia segreta delle famiglie reali» narra che nei
sotterranei dell’Inquisizione di Madrid i buoni padri domenicani
immettevano il piombo bollente liquefatto nella natura delle donne
accusate di eresia.
E il re Filippo II sadico e mostruoso paladino del fanatismo cattolico assisteva a quegli spettacoli, godendone.
L’Inquisizione fu il prodotto di un’alleanza fra la chiesa e la
monarchia, alleanza che, per circa cinque secoli, permise ai tribunali
ecclesiastici di giudicare e condannare a morte gli eretici che poi
venivano consegnati al braccio secolare per la esecuzione della
sentenza. Ed ancora oggi la chiesa, attraverso i suoi teologi, rivendica
il diritto di ripristinare quello stato di cose.
Nell’opera «De
stabilitate et progressu dogmatis», approvata dal Papa Pio X e stampata
nel 1910 nella tipografia del Vaticano, il gesuita Lèpicier scriveva:
«Se i tempi non fossero così perversi per la Chiesa, questa dovrebbe
denunziare gli eretici al potere civile, e i re dovrebbero sterminarli
nei loro regni sotto pena di scomunica e di perdita del trono».
Per quanto poi concerne i morti è da notare che i preti cattolici hanno bruciato anche quelli.
I Crociati di Simone di Montfort che, accompagnati e benedetti dal
legato pontificio, sterminarono nel 1209 tutti gli albigesi, aprirono a
Bèziers ed altrove le tombe dei vescovi eretici e ne arsero i cadaveri.
Ma c’è di più. Alcuni secoli prima Papa Stefano II, succeduto a papa
Formoso nella cattedra di S. Pietro, fece disseppellire il cadavere di
Formoso ch’era stato, in vita, suo acerrimo nemico, e lo fece processare
e condannare. Quindi, alla presenza di Stefano e del clero e del popolo
tutto, il carnefice mozzò una mano del morto, gl’insozzò il viso e poi
lo bruciò interamente, gettando le ceneri nel Tevere.
Dunque se
anche il custode del cimitero di Canosa avesse fatto quello che il molto
onorevole Monterisi gli ha rimproverato, non potrebbe proprio uno
zelante cattolico indignarsi per tanto poco. Perché l’anarchico Donato
Giordano avrebbe imitato, debolmente, un pontefice romano.
Mai
l’uomo è stato tanto schifosamente pecora quanto lo è ora. Mai ha
marciato cosi bene nei ranghi, mai ha segnato il passo con perfezione
maggiore, mai ha sentito un timore reverenziale per l’autorità simile a
quello che sente in pieno, stupido, ventesimo secolo. L’umanità si è
trasformata in una moltitudine di fantocci che si sforzano per rendersi
sempre più uguali gli uni agli altri e per pensare, sentire ed agire in
un unico modo, ossia come ì capi stabiliscono.
Basta che appaia
l’uniforme dì un poliziotto e tutti cominciano a tremare e ad
inchinarsi. Trent’armi fa, a Napoli, quando una guardia municipale
comunicava ai vetturini da nolo che, per ordine del Sindaco, non
potevano fermarsi in una certa piazza o in un altro luogo, tutti i
vetturini, per istintiva ribellione alla legge, sostavano nel luogo
vietato. E se la guardia voleva elevare contravvenzione, essi scendevano
dalle carrozze, con le fruste in pugno, e la facevano fuggire. Oggi un
tale spettacolo d’indisciplina non si osserva più; prima ancora che il
vigile abbia finito di parlare tutti gl’i autisti e i vetturini eseguono i suoi ordini.
Gl’imbecilli dicono che questo è progresso. Ma io aggiungo: nel
pecorismo. La vita è sempre più meticolosamente ordinata, regolata,
uniformata, civilizzata, ma gl’individui diventano tante marionette
identiche che si muovono come vogliono i burattinai che tirano i fili. E
gl’impostori, i politicanti, i demagoghi profittano del generale
gregarismo per metamorfosarsi in duci venerati, in capi eccelsi, in
esimi manovratori dei pupazzi che credono, ubbidiscono e si lasciano
fregare.
Oggi un qualunque pulcinella che urla in piazza: «ho
scoperto la ricetta infallibile della felicità universale. Ho trovato il
paradiso terrestre. Seguitemi e vi ci condurrò», trova subito centomila
tessi o un milione di pecore che bevono le sue panzane, gli battono le
mani e si fanno dirigere e comandare, da lui. Cosi il pulcinella forma
un partito; e, se nella lotta contro i pulcinelli rivali, che sono alla
testa dei partiti opposti, riesce ad ottenere la vittoria diventa capo
dello Stato e dittatore. Allora, come prima cosa, comincia ad opprimere,
a sfruttare a spogliare il popolo idiota per ben riempire le tasche sue
e quelle dei pulcinellini che lo circondano, dei gerarchi e gerarchetti
che lo aiutano ad imbonire la massa. Ma questa massa quanto più è
frustata e tosata, tanto più continua a curvare il groppo e a gridare:
«il duce è grande. Il duce è sublime. II duce ha sempre ragione». E il
duce, a furia di sentir ripetere ch’egli è grande, è sublime, è un dio
in terra; a furia di veder tutti curvi che prodigano laudi e bruciano
incenso davanti ai suoi piedi; si esalta, si suggestiona finisce per
credere veramente ch’egli è il padreterno o ch’è investito di una
missione divina. Per conseguenza vuole cambiare la faccia del mondo,
vuole creare la nuova umanità di tipo unico, cioè del tipo che a lui
piace, vuole immortalare il suo nome, estendendo il suo dominio
sull’intero globo e realizzando in esso il suo ideale. Nella sua anima
impera uno strano miscuglio di egoismo e di fanatismo e la sua volontà è
determinata non solo dal bisogno di opprimere e smungere i gregari per
vivere bene la sua vita, ma anche dall’assillo di utilizzare questi
gregari come mezzi per la creazione del suo capolavoro, del nuovo ordine
universale ch’egli vuole instaurare. Quindi Hitler scatena la guerra
sognando la Germania padrona della terra e la razza tedesca che lo adora
come dio e domina ed elimina le razze inferiori. Quindi Mussolini
farnetica la ricostruzione dell’impero romano e lancia l’Italia allo
sbaraglio. Quindi Stalin riduce nella miseria e nella schiavitù duecento
milioni di slavi per procurarsi la forza e la ricchezza che gli
permetteranno domani d’imporre la bolscevizzazione del mondo.
Ma se
questi falsi grandi uomini, se questi despoti odiosi, per metà preti e
per metà filibustieri, possono calpestare l’umanità e travolgerla nel
abisso, la colpa è pur sempre dei popoli che li innalzano, li seguono e
si fanno scannare. Se non c’è il servo non può esservi il padrone. Ergo:
gli uomini hanno ciò che meritano.
E Mussolini, Hitler, Stalin,
Franco, Peron, ecc., sono i degni pastori del gregge umano del ventesimo
secolo, stupido e rognoso.
Ma per distruggere il gregarismo non
basta trasformare l’organizzazione, politica ed economica, della
società, passare dallo stato borghese allo stato socialista, o pure
abolire lo stato e sostituirlo con la federazione dei comuni autonomi
che sarebbe un nuovo Stato camuffato.
Per annientare il gregarismo
occorre risvegliare in ogni individuo l’istinto naturale della libertà,
l’insofferenza d’ogni catena, i sentimenti individualisti, il bisogno
dell’espansione. Per natura, l’uomo nasce anarchico. Il bambino, appena
uscito dal grembo materno, vuole muoversi a piacer suo, allungare o
ripiegare le gambe, tendere le braccia, rivoltarsi nella culla; e quando
la madre lo stringe nelle fasce che paralizzano la scioltezza dei suoi
movimenti, egli si ribella e protesta col pianto. Il bambino sente
dunque istintivamente che la libertà personale è la condizione
necessaria per vivere con intensità. Ma questa sua tendenza spontanea
viene subito compressa dai genitori che gl’impongono, con l’educazione,
la suggestione e il castigo, di non fare quello ch’egli vuole ma solo
ciò che babbo e mamma comandano.
Divenuto più grandicello il bambino
viene mandato nella chiesa dove il prete gl’insegna ad ubbidire a Dio e
a temerne l’ira. Poi entra nella scuola nella quale il maestro gli dice
che non deve vivere per sé ma per rendersi utile alla società ed
assolvere i doveri che questa gli prescrive. Infine, divenuto adulto, fa
il suo ingresso nella vita sociale ed è costretto ad uniformarsi a
tutte le leggi, le regole, le convenzioni per evitare le pene della
galera, i tormenti della miseria e il disprezzo e le persecuzioni della
gente onesta. Così, poco a poco, sottoposto a tante influenze
narcotizzatrici e a tante coazioni soffocatrici, l’uomo ricaccia nei
meandri del suo subcosciente l’istinto naturale della libertà ed
acquista abitudini e bisogni gregari. Ma è appunto da tali abitudini e
da tali bisogni ch’e necessario affrancarlo. E per riuscire a canto
occorre convincerlo ch’egli non è nato per ubbidire ma per essere
libero; che non deve soffocare i suoi impulsi naturali ma seguirli senza
vergognarsene; che non deve sottostare a nessuna disciplina e a nessuna
norma, ma fare tutto quello che gli pare e piace perché nulla esiste
che sia proibito o permesso, ma tutto è lecito per chi ne ha la forza.
Se molti uomini si convinceranno di ciò e agiranno in conseguenza, la
società organizzata si sfascerà, cadranno tulle le catene religiose,
etiche e giuridiche, e avremo il ritorno alla natura e il trionfo della
libertà istintiva dell’individuo. Se invece solo pochi uomini rimarranno
convinti, questi pochi ostacoleranno, col pensiero e con l’azione, la
crescenza spaventosa del gregarismo nella nostra specie e l’assoluta
identificazione dell’uomo con la pecora, ma non potranno rinnovare il
mondo.
Trotskij narra nelle sue memorie che, avendo chiesto ad un
anarchico, suo compagno di galera, come avrebbero funzionato le ferrovie
in un mondo senza autorità e senza Stato, ebbe questa risposta: «Se non
potranno funzionare, ne faremo a meno». Allora, aggiunge Trotskij,
compresi che non valeva la pena di parlarne più; cioè che l’Anarchia è
un’assurdità.
Ma un tale giudizio non può essere dato che da chi è affetto dall’inguaribile miopia dei marxisti.
La libertà è per l’uomo mille volte più necessaria di tutti i treni, le
macchine, gli aeroplani e le radio. Un individuo libero nel mezzo di un
bosco dove vive da selvaggio si sente soddisfatto e contento come non è
il miserabile gregario imprigionato nella civiltà e costretto a fare
sempre quello che vogliono gli altri e mai ciò che lui vuole.
Con
ragione i filosofi cinici identificarono la felicità con l’indipendenza.
Antistene e Diogene insegnarono che l’uomo deve cercare di bastare
quanto è più possibile a se stesso e deve appagare i soli bisogni
naturali, rinunziando a quelli artificiali che lo rendono schiavo della
società. L’uomo vero ch’essi intendevano realizzare era l’uomo dello
stato di natura; famiglia, città, diritti politici erano convenzione e
artificio per i cinici che dichiaravano che il saggio è cittadino del
mondo.
Prima ancora, i sofisti avevano compreso che l’anarchia è la
sola forma di vita per la quale l’uomo è nato. E Protagora, negando
l’esistenza d’ogni norma universale, aveva affermato che l’individuo è
la misura di tutte le cose; e Callicle si era scagliato contro
l’educazione che toglie ai fanciulli ogni natio vigore, li rende inetti,
li uguaglia tutti e li avvezza all’ubbidienza servile; e Archelao aveva
detto che il bene e il male non sono per natura ma per convenzione, che
il più forte fa la legge e stabilisce anche ciò che bene e ciò ch’è
male, che la legge è fatta solo per l’uomo che non ha la forza o
l’audacia di sottrarvisi, e chi ha per sé la forza può ridersi di tutte
le leggi, e ciò che appare giusto può ben dimostrarsi ingiusto.
Nel
medioevo il filosofo arabo Abubacher nel suo romanzo «Il vivente»
dimostrò la superiorità della vita libera e senza freni dello stato di
natura sulla vita, schiava ed infelice, che vive l’uomo nella civiltà.
Sopravvenuti i tempi moderni il fine Rabelais suggeriva all’uomo «fais
ce que veux», e nel secolo scorso Stirner e Nietzsche demolivano tutte
le pastoie religiose, morali, sociali che opprimono l’individuo e
incitavano quest’ultimo ad appagare il suo egoismo senza curarsi di
altro.
Dunque, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, dei grandi
pensatori, non asserviti al gregge e ai suoi pastori, hanno fornito la
giustificazione razionale di quel profondo bisogno che gli uomini non
addomesticati avvertono: vivere, seguendo la propria spontanietà, nella
più ampia libertà.
Se filosofi appartenenti a scuole diverse hanno
riconosciuto in ogni epoca che il fine dell’uomo non è sottomettersi
agli altri ma sciogliersi da tutti i ceppi per muoversi a piacere suo,
ciò significa che l’Anarchia non è un’assurdità come riteneva Trotskij;
mi è lo stato di natura che, se sarà restaurato, offrirà nuovamente agli
uomini la gioia di esistere che essi hanno perduto, da millenni, e che
ancor peggio perderebbero nella caserma bolscevica, trotzkista o
staliniana.
«Caro Martucci, quando si parla con voi, ci si sente
bestia. Solo che bestie non potremo ritornare tutti perché l’uomo si è
abituato alla civiltà e non sa vivere fuori da questa».
Così mi ha
detto una giovane e graziosa pittrice. La quale, evidentemente, ha
voluto ripetere nei miei riguardi il giudizio che Voltaire emise e su
Rousseau; «Quando lo si legge si avverte il bisogno di camminare a
quattro gambe».
E a lei è sembrato che un simile giudizio fosse più
adatto per me che per Rousseau. Perché mentre Gian Giacomo, pur
sostenendo la superiorità dello stato di natura sulla vita civile,
credeva impossibile un ritorno ad esso dell’intero genere umano e
consigliava a quest’ultimo di accettare la democrazia come il minor male
necessario, io penso invece che la nostra specie potrebbe ritornare o
riavvicinarsi ai primordi. Cioè potrebbe risvegliare in sé gl’istinti
sopiti e le tendenze naturali che la spingono verso la libertà più
sfrenata; ripudiare ogni legge, ogni autorità, ogni disciplina, ossia
lutto quello che rappresenta la condizione indispensabile per la
conservazione della società organizzata e della civiltà artificiale; e
realizzare una vita anarchica che si svolgerebbe attraverso innumerevoli
forme le quali andrebbero dallo stato primitivo, puro e semplice, allo
stato semiprimitivo fino alla libera civiltà, aderente alla natura e mai
staccantesi da questa, che sarebbe prodotta da gruppi e da comunità di
contadini, di artigiani, di artisti e di pensatori, liberamente
associati.
Ma ad una tale vita non saprebbe più adattarsi l’uomo che
ha acquistato abitudini gregarie e bisogni artificiali, osserva la
pittrice. Però io richiamo la sua attenzione su di un fatto: l’uomo si è
abituato alla scienza del gregge la giudica bella e buona, la ritiene
necessaria, coltiva i sentimenti pecorili e i bisogni innaturali che la
Società gl’instilla; ma in lui rimane pur sempre, soffocato e represso,
il bisogno istintivo della libertà e soffre per l’impossibilità di
soddisfarlo. Prendiamo, ad esempio, l’operaio. Egli si è abituato ad
entrare ogni mattina alle sei, quando fischia la sirena, nella fabbrica,
imbrancato fra i compagni. Si è abituato a rimanere per otto ore nel
suo reparto, compiendo sempre automaticamente gli stessi gesti e
stancandosi in un lavoro che non lo appassiona perché non richiede
l’impiego dell’intelligenza e della capacità creatrice ma è
meccanicamente eseguito. Tuttavia per quanto sia abituato, per quanto
sia convinto che quella vita è necessaria e deve continuare sempre nello
stesso modo, l’operaio soffre sentendosi rinchiuso nella fabbrica senza
poterne uscire prima che l’orario sia finito; soffre quando, affranto,
non può interrompere il lavoro e riposarsi qualche minuto perché
sorvegliato dall’occhio poliziesco del capo reparto; soffre quando
quest’ultimo lo rimprovera e fa la voce grossa. Il che dimostra che
l’istinto non si adatta mai completamente alla vita schiava della galera
industriale.
Il soldato ritiene che sia suo dovere servire la
patria e ubbidire ai superiori; però la disciplina della caserma non gli
piace, gli ordini, sovente, lo irritano, vorrebbe fuggir fuori ed
essere libero. Si piega infine, ma si piega con dolore, vincendo la sua
natura.
Il fratello che avverte un impulso sessuale per la sorella,
soffoca subito tale impulso se è, come dicono i moralisti, un uomo
onesto, e sente vergogna di sé. Però egli soffre per il mancato
appagamento del suo bisogno incestuoso.
L’affamato che, con occhio
cupido, guarda attraverso la porta del ristorante i cibi succulenti che
mangiano i signori, tende istintivamente a lanciarsi ad afferrare i
piatti, a riempire lo stomaco vuoto. Si frena pensando che sarà
arrestato, condannato come ladro, coperto d’ignominia. Ma spasima
frenandosi.
In tutti, dunque, anche nell’individuo più gregarizzato
si rivela la tendenza a soddisfare i propri bisogni a fare come gli
pare, a muoversi a piacer suo. Questa tendenza il gregario cerca
soffocarla in sé; ma non riesce mai a distruggerla del tutto. La
indebolisce reprimendola continuamente, ma mai può annientarla. Anzi in
taluni la repressione esaspera la tendenza coartata.
Quindi se gli
uomini si decidessero a non imbrigliare più la loro natura e a seguirne
gl’impulsi, trattenendoli solo quando un’estrema necessità lo esige e la
forza della volontà lo consente, allora essi, restituiti alla
spontaneità per la quale sono nati, sentirebbero un piacere intensissimo
e si troverebbero tanto a loro agio che rinunzierebbero facilmente alle
abitudini gregarie e ai bisogni artificiali succitati dalla società per
mantenere la schiavitù. E i loro figli, generati in un ambiente libero,
allevati naturalmente come l’Emilio di Rousseau, sarebbero ancora più
naturali e spontanei dei loro padri. L’umanità, infine ritroverebbe la
sua vita.
Del resto l’odierna civiltà industriale meccanica è
destinata a scomparire anche se non vi sarà il risveglio anarchico
dell’individuo umano. E dovrà morire per la stessa ragione per la quale
sono morte le altre civiltà che l’hanno preceduta. Perché si sono
staccate troppo dalla natura, si sono contrapposte ad essa e, con la
pretesa di migliorarla e correggerla hanno spinto gli uomini e
soffocarla con i loro freni e a falsarla con gli artifici. E la natura
che, se cambia vuole cambiare da sé non per costrizione dell’uomo, si si
è vendicata determinando gli uomini a distruggere le civiltà e
loro stessi.
Alcuni scrittori sostengono che gli abitanti della sommersa Atlantide
avevano raggiunto un grado elevatissimo di cultura e d’incivilimento.
Essi erano riusciti a scoprire e a dirigere una misteriosa forza della
natura, una formidabile energia ipnotica, il Vril, col quale agivano non
solo sugli altri uomini ma anche sulle cose materiali. Così operavano
prodigi incredibili, costruivano monumenti giganteschi obbligando i
macigni a sovrapporsi, deviavano con la volontà il corso dei fiumi, ecc.
Ebbene essi finirono col servirsi del Vril nelle loro guerre intestine e
provocarono tali cataclismi che
sprofondarono il continente nel mare.
Ora, se in tutto ciò vi è esagerazione e fantasia, non è però da
escludere che l’Atlantide e gli abitanti — dei quali anche Platone
assicura che sono realmente esistiti — siano scomparsi in seguito
all’uso di una misteriosa forza naturale che avevano scoperto e
largamente impiegata.
Gli antichi egiziani erano riusciti anch’essi
ad impadronirsi di energie sconosciute e si dice che i templi di Tebe
fossero illuminati da una magica luce simile a quella del Sole. Pure,
guerre e flagelli d’ogni genere distrussero la civiltà egiziana che non
risorse mai più.
Attualmente noi, dopo aver compresso la natura in
tutti i modi, dopo di avere turbato il suo equilibrio con ogni sorta di
sovversioni, dopo che abbiamo impiegato alla cieca certe sue forze che
non sappiamo da cosa provengono e quali effetti producono nei rapporti
tra gli elementi cosmici, siamo giunti al punto di disintegrare l’atomo e
di sprigionare quella formidabile energia che la natura ha concentrata
tutta nella particella piccolissima di materia perché, per la natura, è
necessario che in essa rimanga. Noi, invece, abbiamo voluto
impadronircene e servircene per i nostri fini. Ma sarà proprio questa
energia da noi imprudentemente sprigionata ed usata, che ci distruggerà.
La prossima guerra che scoppierà inevitabilmente — se una rivolta
anarchica degli uomini contro i loro governi, le loro forme sociali e la
loro tirannica civiltà non saprà prevenirla — sarà combattuta con la
bomba atomica. E centinaia di queste bombe annienteranno, con la loro
spaventosa potenza distruttiva, non solo la civiltà industriale
meccanica, non solo le immense metropoli, ma anche l’intera specie
umana.
Probabilmente moriremo tutti. Ma potrà anche accadere che
pochi riusciranno a salvarsi. Costoro, però, saranno affetti da
degenerazione dovuta agli effetti dei raggi provenienti dalla
dissoluzione dell’atomo. Nasceranno creature corrotte da vizi
fondamentali del corpo, bambini con sei dita e bambine con otto paia di
mammelle, (1) come ha previsto lo scrittore Aldous Huxley nel suo
recente romanzo «Ape and Essence» (La scimmia e l’essenza). I
sopravvissuti, ridotti in uno stato inferiore a quello bestiale, non
sapranno più coltivare né tessere, anzi non potranno più coltivare
perché il terreno sarà stato consumato dalle erosioni e sterilito dai
raggi. E per difendersi dal freddo dovranno scavare fra le macerie i
cadaveri e togliere loro i vestiti.
Agli uomini dunque, s’impone
oggi il dilemma: o ritornare alla natura di cui sono parte e armonizzare
col tutto senza più pretendere di cambiarlo, di correggerlo di
governarlo; o continuare a tiranneggiare la natura per essere poi
annientati dalla rivolta di essa e respinti allo stato delle bestie
inferiori al di sotto dei serpenti e dei rospi.
L’uomo è avvisato. Scelga come vuole.
La rivista «L’Unique» giugno 1949, dimostra, con dati statistici, lo
spaventoso aumento della specie umana che avanza allegramente verso la
cifra di tre miliardi d’individui e finirà per morire di fame perché i
prodotti della terra non basteranno a soddisfare i bisogni di tutti. E
da quest’amara previsione l’organo di Armand — partigiano della
limitazione delle nascite — desume la necessità di «proteggere la natura
contro i suoi propri eccessi».
Però io credo che la
superpopolazione del globo non sia dovuta ad un eccesso della natura, ma
alla civiltà, alle morali e alle leggi che l’uomo si impone.
La
natura ci ha dato la tendenza ad appagare la nostra sessualità in un
modo che conduce alla riproduzione. Ma ci ha dato anche la tendenza a
cercare, oltre questo modo, altre forme di piacere erotico che escludono
la conseguenza dei figli. (1) L’inclinazione al cunnilinguismo nel
maschio e al fellatorismo nella femmina, il bisogno del coito anale che,
da molti, è più apprezzato del coito comune, e tanti altri impulsi che
ci spingono verso le cosiddette depravazioni, provengono dalla natura e
permettono la soddisfazione di esigenze eterosessuali non causanti la
procreazione. E tale istinto esiste sia negli uomini, civili e selvaggi,
sia nelle bestie. Karsch, nella sua interessante opera «Uranismo o
pederastia e lesbismo fra gli animali», ha dimostrato che
l’omosessualità è diffusissima nei mammiferi, uccelli, pesci, insetti,
ecc. Dunque se l’uomo appagasse le sue diverse tendenze secondo il
capriccio dell’istante; se cioè soddisfacesse or questa, or quella
tendenza nel momento in cui si manifesta più forte delle altre, allora
sarebbe portato a godere in vari modi e le nascite diverrebbero meno
frequenti.
Invece, da millenni, la civiltà prescrive all’uomo,
attraverso le sue morali e le sue leggi, di godere in un modo unico,
ossia nel modo che causa la riproduzione. Moltissimi che sentono il
bisogno di gustare altre forme di piacere, sono costretti ad astenersi
perché terrorizzati dall’idea del peccato che commetterebbero, della
punizione divina che piomberebbe sulle loro teste e del disprezzo con
cui gli uomini li bollerebbero se sapessero che essi sono depravati e
amorali. Altri ancora, che se ne infischiano dei pregiudizi; debbono
rinunziare ugualmente alle voluttà proibite per paura della repressione
legale e del carcere. Quindi, ad eccezione degli anticonformisti che
sfidano la società o riescono a soddisfarsi nascosta mente la grande
maggioranza degli uomini è obbligata a sfogare la propria libidine nella
sola forma sessuale permessa. E allora come stupirsi
dell’impressionante aumento della specie e perché darne la colpa alla
natura che, se lasciata libera, non avrebbe prodotto eccessi?
Nello
stato primitivo non esiste proprietà privata: la terra e tutte le
risorse della natura sono a disposizione di tutti e ciascuno può
servirsene come meglio crede. Nello stato di civiltà alcuni uomini si
sono impadroniti della terra e di ogni altro mezzo di produzione creato
dalla natura o dal lavoro umano, ed hanno detto: questo è nostro.
Gli altri, cioè la stragrande maggioranza degli uomini rimasti privi di
ogni cosa, debbono rassegnarsi a lavorare come schiavi per conto dei
proprietari che li sfruttano esosamente, pagandoli con miseri salari. E
coloro che i padroni non ingaggiano, coloro che rimangono disoccupati
sono condannati a morire lentamente di fame. Se si ribellano, se si
servono di qualunque mezzo per strappare ai signori quel pane che i
signori loro negano, lo Stato li sbatte in galera o li uccide sulle
piazze e tutti i pecoroni, onesti e perbene, li condannano.
Perfino
Errico Malatesta, che si dichiarava anarchico e predicava
l’espropriazione rivoluzionaria della proprietà privata, definì «ladro
volgare e delinquente» l’anarchico individualista Jules Bonnot che,
insieme a pochi compagni, negli anni 1912 e 13, assaltò e svaligiò, con
audacia incredibile, parecchie banche e gioiellerie di Parigi; e cadde
infine, con l’arma in pugno, in un cruento conflitto con la polizia che
cercava arrestarlo.
Secondo Malatesta l’azione di Bonnot era da
deprecare perché l’espropriazione dev’essere collettiva e non
individuale; con la prima si ottiene una trasformazione radicale della
società umana e la eliminazione dei mali che la proprietà privata
produce; con la seconda, invece, tutto rimane com’è e non si ha che il passaggio della proprietà da un individuo all’altro.
Il ragionamento di Malatesta sembra che fili, ma non fila affatto.
Perché se io, anarchico, incito gli schiavi alla rivolta e
all’espropriazione dei beni che dovranno essere messi in comune; e
questi schiavi, paralizzati dal gregarismo, istupiditi dai precetti
religiosi e morali, terrorizzati dalla legge e dal gendarme, non mi
ascoltano e sopportano rassegnatamente la frusta e la fame; allora io
non posso rimanere pecora perché pecore vogliono rimanere gli altri. A
questi non sono legato, non sono costretto ad agire com’essi agiscono,
ma debbo vivere per me, a modo mio. Debbo realizzare immediatamente la
mia completa liberazione che, per me, è più importante della liberazione
di un’umanità che bacia la mano che la sevizia. Dunque insorgo da solo;
e se riesco e sfuggo alla morte, ho i mezzi per vivere bene, per non
farmi sfruttare, per procurarmi soddisfazioni e per combattere più
efficacemente la società che detesto.
Non è vero che tutto rimane
come prima; perché c’è uno schiavo di meno. E l’esempio di questo
schiavo che infrange la catena scuote anche quegli altri schiavi, non
ancora impecoriti e rassegnati completamente, e li sprona a seguire
l’illegalismo del ribelle. L’azione influisce meglio dei discorsi sul
risveglio degli uomini; di guisa che se colpisco la proprietà privata,
altri imitandomi, la colpiranno pure ed essa s’indebolirà sempre più
mentre lo spirito d’insofferenza, d’irriverenza, d’iconoclastia e
d’insurrezione si svilupperà maggiormente (1).
Gli espropriatori
anarchici, non s’imborghesiranno dopo l’espropriazione, come temeva
Malatesta. Ma avranno migliori possibilità di lotta contro la società
che odiano. Ed anche se qualcuno s’imborghesirà, il passaggio della
proprietà privata dalle mani dell’uno alle mani dell’altro non sarà
stato inutile nemmeno in questo caso. Ma avrà servito a fare si che a
godere non sia sempre uno e a soffrire sempre un altro. E che vi sia
almeno un po’ di rotazione.
Il Papa ha scomunicato i bolscevichi per
indicarli all’odio dei cattolici fanatici e dare alla prossima guerra
contro la Russia il carattere di crociata, in difesa della fede, per la
vittoria sugl’infedeli. Pio XII li ha anatemizzati in nome di Cristo,
ch’egli dice di rappresentare sulla terra e mostra l’anima della
legittima autorità opposta alla tirannide degli usurpatori rossi.
Stalin, dal canto suo, nei paesi che domina, cerca creare le chiese
nazionali, sottoposte allo Stato, quindi nemiche del Vaticano e
dipendenti dal Cremlino. In Ungheria, in Polonia,in Cecoslovacchia,
ecc., i seguaci del truce georgiano esaltano costui come il vero
continuatore dell’opera di Cristo che, tradita ed abbandonata dai
Pontefici romani, è oggi portata a termine dal già ateo dittatore al
quale nel gennaio 1946, il vescovo di Leningrado diceva: «Voi siete
l’incarnazione di ciò che vi è di meglio nelle tradizioni religiose
russe: è grazie ai soviet che la chiesa ha raggiunto una prosperità
spirituale che, da secoli, non aveva mai visto».
Dunque Cristo è, al
di qua del sipario di ferro al servizio degl’interessi del capitalismo
anglosassone e del sogno teocratico di Pio XII; al di là del sipario è
uno strumento per il trionfo dell’imperialismo russo e del dominio
universale del piccolo padre Stalin.
Ma vi è una seria ragione per
cui tutti coloro che vogliono comandare e divenire padroni assoluti
dell’umanità, si pretendono rappresentanti di Cristo e prosecutori della
sua opera. Perché Cristo incarna il principio dell’autorità divina
contro la quale ogni rivolta è sacrilegio. Perché predica l’ubbidienza
ai superiori e la rassegnazione al dolore e, quindi induce i popoli a
sopportare la schiavitù e a non cercare di sottrarsi alle pene che lo
stato di schiavo comporta. Perché consola con la promessa della
ricompensa nell’altra vita e fornisce quella speranza senza la quale gli
uomini insorgerebbero per vivere meglio su questa terra.
Ecco il
motivo per il quale tanto il papa, quanto Truman e Stalin, parlano in
nome di Cristo e preparano, per la sua gloria, il futuro macello.
Ma
proprio perciò coloro che aspirano a non rimanere vittime della bomba
atomica e del raggio cosmico, coloro che non vogliono farsi scannare per
Stalin o per i capitalisti yankee, ma aspirano invece alla conquista
della libertà: debbono riunirsi intorno alla nera bandiera
dell’Anticristo.
Questa è simbolo di anti-autorità, di anti-Stato,
di antigregge. Sventolando, schiaffeggia gl’impostori che governano,
sveglia i servi che dormono, sprona i rassegnati a scuotersi
dall’inerzia ed a lottare attivamente per una vita migliore.
Smaschera tutti gl’inganni con i quali, da migliaia di anni, l’uomo è
stato convinto a caricarsi di catene e a soffocare la natura e
gl’istinti. Svela infine l’ultima, gesuitica menzogna che, conferendo
alla guerra imminente il crisma della santità e della benedizione
divina, spingerà gli schiavi a massacrarsi, come sempre, per una causa
che non è la loro.
La bandiera dell’Anticristo è il segno della
riscossa. E’ il labaro di un impulso che potrebbe ancora im-pedire il
cruento conflitto e rigenerare l’umanità nell’anelito dell’Anarchia. Ed
anche se le masse, stupide e pecorili, non sapranno riconoscerla e non
vorranno salvarsi accettandola come loro vessillo, essa rimarrà — fino
al vicino giorno della pan distruzione — il drappo di quei pochi che
opporranno il tragico no di una disperata rivolta al sì generale dei
popoli incretiniti e condotti al macello.
Cosi la nera bandiera dei
reprobi e dei fuorilegge, la bandiera corsara di Stirner e di Bonnot,
sarà l’animatrice dell’ultimo eroismo nel turpe mondo gregario che la
bomba atomica inabisserà.
Il giornale dei faisti «Umanità Nova» (che
Mario Mariani chiama, con ragione, «Umanità decrepita»), ha pubblicato
nel suo numero del 2 ottobre 1949 uno scritto dallo stile contorto e
confuso e dal titolo « Indisciplina fine a se stessa?».
Leggendo
quest’articolo mi è riaffiorata alla memoria la vecchia massima latina
«Sutor, ne ultra crepidam » il cui senso suona: «Ciabattino, non
permetterti di andare al di là della ciabatta. Non parlare di ciò che
non puoi capire ».
Infatti l’autore dell’articolo — che si firma con
lo pseudonimo di Taglia — rivela la mentalità, vanesia e saccente, del
maestrino, ben imbottito di frasi fatte e di precetti convenzionali, di
menzogne scolastiche e di presunzione educativa. Cioè la mentalità del
fesso che si dà delle arie e che,è la meno adatta per comprendere e,
tanto meno, per criticare due supreme espressioni dello spirito
anarchico: l’individualismo e l’indisciplina.
Da queste due
espressioni deriverebbero, secondo Taglia, non solo il Risorgimento
«svoltosi per episodi individualistici», ma anche l’interventismo, il
dannunzianesimo e, infine il fascismo del «io non adoro la massa», della
«vita dura» dell’uomo forte»,«dell’eroe» ; ossia il fascismo che «su
questi temi puramente individualistico - eroici imbastisce il suo
anti-borghesismo, espressione ultima di una piccola borghesia insaziata
di sensazioni, inguaribilmente malata di nazionalismo, di volontarismo,
del bel gesto, di giovinezza, di guerra igiene del mondo».
Ora se è
vero che il fascismo ha avuto, nella sua iniziale propulsione,
degl’impulsi individualistici e nietzschiani, (l’insofferenza
all’adattamento gregario, il bisogno di affermarsi e prevalere, la
smania della lotta e dell’attacco), è anche vero che il fascismo ha
potuto stabilirsi come dittatura proprio perche nella stragrande
maggioranza degl’italiani abbondava il pecorismo, l’inclinazione a
sottomettersi al forte, a farsi comandare e dirigere. Se gl’italiani
avessero avuto lo stesso spirito, individualista e nietzschiano, dei
primi fascisti; se avessero voluto, come loro, vivere intensamente, non
sopportare freni e correre allo sbaraglio piuttosto che chinare la
testa; allora si sarebbero ribellati all’aggressione fascista, avrebbero
contrapposto « volontà di vita» a «volontà di vita», manganello a
manganello, bomba a bomba, e non sarebbe stata possibile l’instaurazione
della dittatura mussoliniana né di qualunque altra.
L’equilibrio
non si forma che fra uguali, fra uomini fieri, fra individui che pur
essendo naturalmente diversi, sanno però tutti difendere la loro
libertà, servendosi di ogni mezzo. In questo caso essi si contengono a
vicenda e nessuno riesce ad opprimere l’altro che si fa uccidere,
resistendo e colpendo, piuttosto che piegarsi.
Ma se invece da una
parte c’è un gruppo di lupi e dall’altra un gregge di pecore stupide e
belanti, è naturale ed inevitabile che i primi divorino le seconde.
Dunque la vittoria del fascismo non è dovuta tanto allo spirito
individualista e battagliero dei primi fascisti, quanto alla mancanza di
spirito individualista, ossia al gregarismo, degl’italiani.
E se si
vuole impedire che nuove esperienze fasciste vengano a deliziarci, non
si deve predicare la cristiana e dolciastra morale del «rispetta il tuo
prossimo», del «limitati e sii virtuoso», del «ricordati che la tua
libertà finisce dove comincia quella degli altri».
Questa morale non
riesce, in ultima analisi, che ad addormentare gli uomini, privandoli
di ogni energia naturale e lasciandoli senza difesa alla mercé di coloro
che hanno la saggezza di seguire il solo istinto.
Occorre invece
dire ad ognuno : «Sii individualista. Vivi a modo tuo. Non lasciarti
sacrificare. Se il tuo vicino ti attacca, non sottometterti, non
umiliarti, ma difenditi. Cerca moltiplicare le tue forze cerca
acquistarne delle nuove. Muori piuttosto che rinunziare alla tua
libertà».
E se gl’individui accetteranno e praticheranno questi
consigli che trovano riscontro nella loro natura, sbarazzatisi dalla
soffocazione della disciplina e dell’educazione sociale, nessuna
dittatura — fascista o no — potrà più insediarsi e la schiavitù sparirà
da un capo all’ altro del globo. Ma, secondo Taglia, il tipo « che
costruisce il mondo intorno all’asse della propria persona, rimane fuori
di un tempo in cui la scena è calcata, per la prima volta, con piede
sicuro, da masse sociali, fuori di un tempo in cui la svolta storica è
al comunismo (non bolscevismo); in cui le soluzioni sociali e morali
sono soltanto nella collettività come garanzia sicura della libertà
economica e della formazione libera della personalità del singolo».
Però come si possa ottenere la formazione libera della personalità del
singolo, quando questo singolo è ridotto ad una pura recettività
dominata dall’azione esterna, e le soluzioni sociali e morali non deve
cercarle in se stesso ma deve accettarle dalla collettività organizzata,
comportandosi con gli altri non nel modo ch’egli sente e trova migliore
ma bensì nella maniera che la maggioranza gli prescrive; questo è un
mistero che il solo Taglia riesce a conoscere. A me sembra invece che la
sua Anarchia che non tende a decomporre la società presente in
individualità libere, autonome, decentrate, ma vuole trasformarla in una
nuova società più casermistica dell’attuale; in una società omogenea,
con un solo sistema economico, con un’unica struttura sociale, con una
disciplina uniforme stabilita dalle masse che dominano ed alle quali
l’individuo non può opporsi, essendo invece costretto ad accettare da
esse gl’ideali e le norme di condotta; sia una copia, riveduta e
corretta, della Russia bolscevica al cui modello Taglia evidentemente
s’ispira.
Ecco perché si scaglia tanto contro l’individualismo e l’indisciplina. Perché vuole gli uomini in serie, gl’individui fantocci.
L’individualismo, secondo Taglia, spinge l’uomo isolato
«all’incantucciamento, alla ricerca dell’angolino tranquillo dove
disporre in bell’ordine i suoi straccetti intimi, all’arrangiamento
egoistico, in quanto anche un iniziale spirito di lotta o esplode nel
gesto improvviso o si esaurisce in forme di sfiducia che sono il diretto
riflesso della propria impotenza».
Ma anche quando l’individuo si
ribella da solo, «quando compie il bel gesto, non lascia conseguenze
sociali». Ed il suo atto esprime «tutta una situazione sociale già
gonfiata in precedenza e, per questo stesso, rientra nella concretezza
sociale di lotta di masse».
A tali affermazioni dell’aspirante
caporale faista è possibile rispondere in primo luogo che nella
determinazione della rivolta del singolo influiscono, meglio ancora
della situazione sociale, la particolare sensibilità dell’individuo e
l’irriducibilità della sua natura. Talché mentre, nella stessa
situazione, altri si adattano o reagiscono con mezzi meno pericolosi,
egli esplode in una forma eroicamente violenta.
In secondo luogo non
è vero che l’atto dell’isolato non lascia conseguenze sociali. Quando,
agendo solitariamente o in libera e revocabile intesa con pochi
compagni, gli anarchici si chiamavano Henry, Ravachol, Caserio, Bresci,
Bonnot, Novatore, Pollastro, Di Giovanni, essi sconvolgevano la società
costituita, ne inceppavano il funzionamento, accendevano gli spiriti,
portavano nel gregge il soffio della rivolta e la forza della
disintegrazione e, odiati o amati, maledetti o ammirati, s’imponevano
all’attenzione del pubblico e influivano su di esso.
Oggi che gli
anarchici son precipitati dalle vette dell’individualismo, eroico ed
illegalista, nella grigia palude dell’organizzazione partitaria; oggi
che si sono inseriti nella normalità e nella legalità, che son diventati
persone per bene e marciano indrappellati nei ranghi; nessuno più si
occupa di loro, la massa li ignora, non esercitano su essa nessuna
influenza ed il partitino scompare al fianco dei partitoni che
scimmiotta. Ecco dunque il mirabile progresso realizzato dai nuovi
anarchici.
Ma Taglia, non limitandosi a deplorare solo i grandi
ribelli e la sterilità (sic) dei loro atti, si scaglia anche contro
«l’atomizzazione delle volontà», contro ogni forma d’indisciplina,
contro «il tipo napoletano vagabondo, stornellatore, che vive alla
giornata o finisce il suo individualismo, insofferente più di logicità e
di coerenza che non di disciplina, nelle caserme della questura».
Per Taglia che sogna la vita spartana ed il soldato disciplinato, è un
grave male anche «la piccola indisciplina — caos di chi traversa la
strada quando c’è il rosso, di chi va sotto le armi col proposito
d’imboscarsi, di chi diluisce la sua rivolta nei piccoli gesti del
ribellismo quotidiano, della piccola indisciplina, del piccolo
individualismo».
Io credo invece che anche queste blande rivolte e
queste minime indiscipline non siano da condannare ma da incoraggiare.
Perché esse rappresentano un inizio di risveglio della natura soffocata e
compressa dalla coercizione e dall’educazione sodate. Costituiscono una
tendenza dell’individuo a fare come vuole e non come vogliono gli
altri, un’insofferenza della legge che l’obbliga ad agire come tutti
agiscono. Rivelano una reazione della personalità, libera ed originale,
all’assorbimento nella massa gregaria, un desiderio di rimanere se
stesso e di muoversi a modo proprio e non secondo la regola. Sono, in
una parola, il primo sintomo della riscossa individuale. Sono, in
potenza, una forza centrifuga che, sviluppatasi in atto, porterebbe al
dissolvimento di ogni organizzazione sociale e di ogni forma di vita
irreggimentata. E se i caporali faisti, che aspirano alla caserma
perfetta, deplorano queste manifestazioni irrazionali e si sforzano per
indurre l’uomo a segnar meglio il passo, io invece le guardo con
simpatia e godo del terrore ch’esse ispirano a tutti i sagrestani delle
diverse chiese che prosperano nel nostro tempo.
E non trovo, per i sagrestani, che la parola di Cambronne.
Lo scrittore Mario Mariani mi ha invia, una vivace lettera polemica alla quale ho così risposto:
«Caro Mariani,
dalla sua rilevo che lei, pur dicendo di avere imparato da
Sant’Ambrogio che l’uomo non può essere offeso se non da se stesso, è
invece offeso perché le ho mostrato qualcuna delle contraddizioni nelle
quali frequentemente incorre nell’esposizione del suo pensiero. E,
punito dal risentimento, ha ribattuto che io ubbidisco al qui do et
dixit e potrei imparare a riconoscere le mie contraddizioni invece di
rinfacciarle le sue. Però ha aggiunto che «la contraddizione non è in
me, né in lei, ma è implicita nell’argomento nella proposizione e da
essa indissolubile».
Verissimo, Mariani! Sennonché lei si è
dimenticato di spiegare che quando uno accetta un argomento, in cui è
implicita la contraddizione, deve svolgerlo in un senso o nell’altro, ma
non può svilupparlo contemporaneamente nei due sensi opposti nei quali è
possibile risolverlo. Almeno se vuole rimanere sul terreno della
logica. Quindi se l’argomento è, come nel nostro caso, l’antinomia fra
l’individuo e la società, si può ugualmente dimostrare o che tale
antinomia è irriducibile o ch’è risolvibile. Però la prima soluzione
comporta l’eterna lotta fra individuo e società; la seconda ammette la
pacificazione finale mediante il sacrificio del singolo alla massa
organizzata. Ora lei — nemico dello Stato, della legge, dell’autorità in
nome della libertà dell’individuo — pretende potere conservare questa
libertà integrale nella sua futura società socialista nella quale, per
l’interesse generale, sarebbero imposte al singolo solo un piccolo
numero di obbligazioni e sanzioni, strettamente indispensabili,
stabilite dalla maggioranza. Ma questo, caro Mariani, significa volere
che ci sia il giorno quando c’è la notte; mentre, per la logica, se c’è
la notte non c’è il giorno e se c’è il giorno non c’è la notte. Ossia se
c’è la libertà dell’individuo non vi sono le obbligazioni e sanzioni; e
se ci sono le obbligazioni e sanzioni non c’è la libertà
dell’individuo.
Infatti per quest’ultimo le obbligazioni e sanzioni
anche se sono poche, anche se si riducono al solo «non ammazzare e non
rubare», possono essere sentite cerne una coazione soffocatrice tanto
terribile quanto le draconiane leggi di un despota. E questo impedimento
all’espansione della sua vita, al suo modo particolare di sentire, è
ugualmente doloroso per l’individuo sia se gli è imposto dal re Sole o
dal Consiglio dei Dieci o da Masaniello o da un milione di compagni
democraticamente organizzati. (La democrazia è la menzogna di moda).
In secondo luogo ogni società tende, per un impulso dettato dallo
spirito di conservazione, a stabilire nel suo seno il monismo e il
conformismo più assoluto. Palante lo ha egregiamente dimostrato.
Perciò una società, anche se è investita del diritto d’imporre
all’individuo solo poche obbligazioni e sanzioni, cerca continuamente di
annientare il numero di queste e di stroncare dapprima le più gravi
trasgressioni al patto sociale per poi precedere, una volta scomparse le
violazioni importanti, alla soffocazione, con la medesima violenza,
delle violazioni lievi e blande. E ciò fino alla scomparsa di ogni pur
minima violazione cioè fino alla assoluta identificazione nel
sentimento, nel pensiero nell’azione — dell’individuo con la massa
organizzata.
Durkheim — filosofo e sociologo non individualista — ha
sostenuto che le più gravi rivolte dell’individuo contro la società
impediscono un azione troppo tirannica esercitata da quest’ultima
sull’individuo. Oggi infatti che la società non è riuscita ad estinguere
i più fieri attacchi al patto sociale, quegli attacchi che, come
l’assassinio e il furto, minacciano di dissolverlo, stabilisce pene
gravi per tali delitti e pene lievi per quei delitti minori che, come
l’oltraggio al pudore o lo schiamazzo notturno, non costituiscono un
attentato all’esistenza del patto sociale, ma rappresentano sempre una
violazione di certi suoi articoli. Però se la società riuscisse ad
eliminare completamente assassinio e furto le stesse pene gravi che oggi
sanziona per questi crimini le applicherebbe all’oltraggio al pudore e
allo schiamazzo notturno; perché dopo avere ottenuto una prima e più
importante vittoria sull’individuo, piegandolo all’osservanza di ciò che
nel patto è fondamentale ed essenziale, essa vorrebbe piegare
integralmente il singolo anche nelle cose meno importanti, per
assorbirlo sempre più, per immedesimarlo con se stessa. Quindi, in
mancanza di reati gravi, considererebbe capitali i reati oggi stimati
lievi e li punirebbe con la massima severità. Dunque, caro Mariani,
nella sua società socialista senza Stato (Società che, sia detto fra
parentesi, e abbastanza simile a quella dei comunisti libertari suoi
avversari), si comincerebbe col sanzionare la morte contro l’assassino o
il ladro e si finirebbe, dopo 50 anni e in caso di successo, con
l’applicarla contro chi piscia nella strada. Se in una tale società non
vi fosse più Stato ciò avverrebbe solo perché l’individuo sarebbe
perfettamente gregarizzato e assorbito dalla massa conformista che
sostituirebbe lo Stato, e cadremmo dalla padella nella brace...
Io
invece considero l’antinomia fra individuo e società come irriducibile.
Penso che l’uomo, ritornato libero, potrà associarsi, se lo vorrà, con i
suoi simili e collaborare con essi in base ad un contratto che conterrà
anche delle rinunzie ad alcune sue libertà. Ma nel momento in cui vorrò
sciogliermi dal contratto, nel momento in cui non vorrò più
riconoscerlo, nessuno potrà impedirmelo. La società potrà espellermi dal
suo seno, combattermi se la combatterò ma non potrà obbligarmi ad
osservare un patto che io non riconoscerò più e non potrà pronunziare
contro me una condanna morale solo perché avrò voluto riacquistare la
mia libertà piena.
In questo caso il perfetto egoismo, scevro da
ogni vincolo, potrà conciliarsi con l’associazionismo e con la
comunizzazione dei mezzi di produzione Io aderirò al gruppo se mi
piacerà; ci rimarrò anche sempre, se mi farà comodo; uscirò dal gruppo e
mi metterò contro di esso nel momento che vorrò. La maggioranza non
potrà trattenermi né costringermi a seguire il suo modo di vita. Ma
quelli che rimarranno uniti — perché lo vorranno — avranno la facoltà di
praticare qualunque sistema comunista, mutualista, cooperativista o di
altro genere.
La lotta rimarrà, è vero. Ma la lotta è inseparabile
dalla vita. Però essa diverrà lotta libera e, appunto perche tale,
sfocerà nell’equilibrio. Quando ciascuno perderà l’illusione d’ essere
protetto dall’organizzazione sociale, preparerà da sé la sua difesa,
svilupperà le sue forze, imparerà a servirsi di ogni mezzo, si temprerà e
si agguerrirà. Quindi conterrà con la sua resistenza l’attacco
dell’avversario. E se cadrà, cadrà in bellezza. Ma quando il pecorone
fesso rimane tale, fidando nello sbirro e nella società che sono alle
sue spalle, viene fregato non solo dall’aggressore ma anche dalla
società e dallo sbirro che, col pretesto di difenderlo, lo schiavizzano.
La salvezza dell’individuo è nell’individuo stesso. Se egli saprà
diventare «unico» con Stirner, «superuomo» con Nietzsche, «anticristo»
con me; se saprà riacquistare la libertà dei primordi e servirsi
dell’intelligenza e della volontà non più per soffocare, come ha fatto
finora, le tendenze naturali, ma per svilupparle maggiormente, allora si
riscatterà. Altrimenti finirà come merita; sotto la bomba atomica. E
sarà un bene».
Dicembre 1948 - novembre 1949
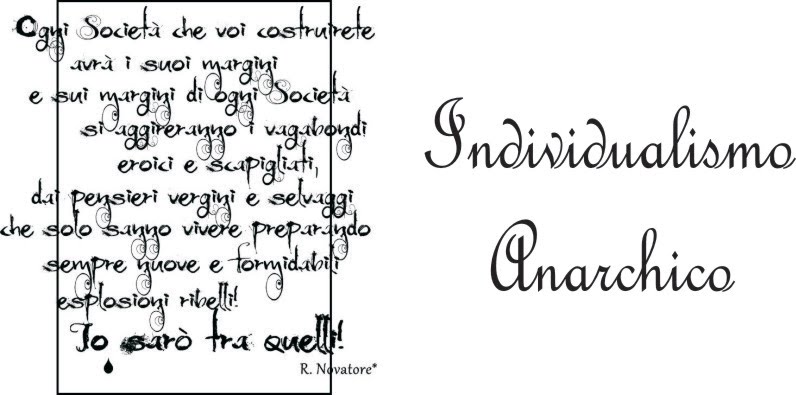

Nessun commento:
Posta un commento